"Dalle stelle al palcoscenico: la scienza secondo Luca Perri"
- Giuseppe Iadonato

- 15 ott 2025
- Tempo di lettura: 10 min
Astrofisico di formazione, divulgatore per vocazione, Luca Perri è una delle voci più brillanti e riconoscibili della comunicazione scientifica italiana!
Lo avete forse visto in TV, ascoltato in radio, seguito in teatro o letto in uno dei suoi libri — sempre con uno stile unico: ironico, diretto, mai banale. In questa intervista, Luca ci racconta il suo percorso tra scienza e divulgazione, le sfide del comunicare il sapere, il valore dell’incertezza nella ricerca e anche qualche lato più personale.
Spoiler: la passione per la scienza non esclude l’umorismo, anzi.
Ciao Luca, ci racconti il percorso che ti ha portato a diventare astrofisico e divulgatore scientifico?
Cosa ti ha spinto verso le stelle... e verso il palcoscenico della divulgazione?
Ho iniziato il mio percorso di studi al Liceo Scientifico, anche se, in realtà, non è un passaggio obbligato per diventare astrofisico: ho colleghi che provengono da altri indirizzi, compreso il Liceo Artistico. Io ho scelto lo Scientifico perché sono cresciuto in una “casa scientifica”: mio padre è medico, mia madre insegnante di fisica.
A un certo punto ho deciso di proseguire con Fisica all’università perché, per me, la fisica era – ed è – un grande gioco. Significa chiedersi il perché di qualunque cosa, proprio come fanno i bambini quando continuano a domandare “perché?”.
Parallelamente agli studi universitari, ho iniziato a fare divulgazione grazie a Bergamo Scienza, uno dei festival scientifici più importanti e longevi in Italia. Da studente, la mia scuola mi portava ogni anno a partecipare come pubblico, poi ho cominciato a intervenire come relatore e oggi ne faccio parte anche come organizzatore. È un percorso che mi ha formato tantissimo.
Se devo indicare un punto di partenza, però, direi che tutto è cominciato a casa: grazie ai miei genitori, e grazie a un libro che ho letto a 10 anni — Viaggio nel cosmo - , di Piero e Alberto Angela. È stato il primo libro di divulgazione scientifica che abbia mai letto, e mi ha fatto scoprire che la scienza non è solo qualcosa da studiare o fare… ma anche qualcosa da raccontare.
C’è stato un momento “decisivo” nella tua vita in cui hai capito che la scienza sarebbe stata la tua strada?
Un episodio, un incontro, una lettura che ti ha fatto dire: “Ecco, voglio fare questo nella vita”?
Sì, direi che il momento decisivo è arrivato, come dicevo nella risposta precedente, attorno ai dieci anni. In quel periodo ho scoperto lo spazio in tanti modi diversi, anche attraverso canali “pop”. Ho visto Star Wars per la prima volta, e poco dopo è uscito Stargate, un film di fantascienza che univa due mie grandi passioni: lo spazio e l’antico Egitto. Da piccolo, infatti, ero indeciso se fare l’astronauta o l’egittologo!
A tutto questo si è aggiunto il libro fondamentale per me, come dicevo "Viaggio nel cosmo". È stato il primo libro di divulgazione scientifica che abbia mai letto, e mi ha davvero aperto un mondo. Lì ho deciso e mi son detto: "ok, farò scienza". E poi, col tempo, ho capito che la mia direzione era l’astrofisica.
Detto questo, le passioni dell’infanzia spesso cambiano, ma nel mio caso c’è stato un incontro che ha confermato quella scelta: il mio professore di scienze al liceo, il mitico professor Germano Federici. È stato lui a trasmettermi per la prima volta il metodo scientifico, con grande entusiasmo. Quell’entusiasmo era contagioso. Direi che lui è stato fondamentale per trasformare una passione da bambino in una vera scelta di vita.
3. Qual è, finora, il momento che consideri il più bello della tua carriera?
Un ricordo che porti con te come un punto luminoso nel tuo percorso.
"Bella domanda! Direi che uno dei momenti più belli della mia carriera è stato quando, in una puntata speciale di Natale di The Big Bang Theory, hanno citato il progetto di ricerca a cui stavo collaborando. È stato davvero emozionante vedere quel lavoro finire, anche solo di sfuggita, in una serie così popolare.
Un anno in particolare che ricordo con grande affetto è il 2014. Ero spesso all’estero per montare telescopi Cherenkov – strumenti ancora poco conosciuti, ma su cui si sta puntando molto per il futuro dell’astrofisica. La squadra con cui lavoro, che ha un cuore tutto italiano e fa capo all’Osservatorio di Milano, è tra le leader mondiali in questo campo. Quell’anno ero continuamente in giro per il mondo, tra conferenze e installazioni. È stato un periodo molto intenso, ma anche incredibilmente gratificante dal punto di vista scientifico."
4. Cosa fai nel tempo libero? Hai passioni al di fuori della scienza che ti appassionano?
Insomma, cosa fa Luca Perri quando non parla di buchi neri?
"Ho altre passioni, eccome! Adoro sia mangiare che cucinare — è la cosa che più di tutte mi aiuta a rilassarmi. Quando sono stressato o nervoso, cucinare è la mia valvola di sfogo.
Poi ho tutte le passioni nerd che potete immaginare: fumetti, cinema, libri... anche se, ultimamente, riesco a leggere solo per lavoro e molto meno per piacere, purtroppo.
Ah, dimenticavo: i LEGO! Sto letteralmente riempiendo casa di mattoncini. È diventata una specie di collezione – e anche quello, ammetto, è un ottimo antistress."
5. Quali sfide incontra oggi chi fa divulgazione scientifica in Italia?
Dal tuo punto di vista, quali sono gli ostacoli più grandi e i margini di miglioramento?
"Le sfide sono tantissime. Una delle principali, a mio parere, è che durante — e forse anche a causa — della pandemia, si è fatto un passo indietro nel rapporto tra scienza e società. C'è stata una crescente sfiducia nella scienza, ma anche in chi la racconta. E dobbiamo essere onesti: parte della responsabilità è anche nostra, della comunità scientifica.
Un altro ostacolo enorme è il vivere in un’epoca in cui tutto deve essere veloce. L’altro giorno ho pubblicato un reel di due minuti e mezzo, e uno dei commenti che ho ricevuto è stato: 'Pensavo fosse un video breve!' Alla fine l’ho dovuto accorciare, perché superava il minuto. Questo è indicativo: oggi abbiamo interiorizzato l’idea che se un contenuto dura più di 60 secondi, non valga la pena apprenderlo. Ma la scienza, per sua natura, richiede tempo. Tempo per essere fatta, ma anche per essere compresa e raccontata.
Questa esigenza di velocità ci porta a semplificare... che va bene, la divulgazione è semplificazione. Ma il rischio è che si scada nella banalizzazione. E quando svuoti i concetti per renderli più “divertenti”, a un certo punto non stai più facendo divulgazione: stai facendo intrattenimento, o peggio ancora, "influencing" travestito da scienza. Alcuni colleghi stanno cercando soluzioni più o meno condivisibili, ma resta il fatto che è una delle sfide più grandi che abbiamo oggi: mantenere il rigore, la profondità e la bellezza del sapere scientifico in un mondo che ti chiede tutto subito e in pillole."
6. Secondo te, qual è il miglior modo per contrastare le fake news nel campo scientifico?
Che ruolo hanno scienziati, giornalisti e pubblico in questa battaglia?
"Credo che il modo più efficace per contrastare le fake news scientifiche sia spiegare come funziona davvero la scienza. Non solo i risultati, ma soprattutto i suoi tempi, i suoi metodi, e anche i suoi limiti. Perché di fake news ne nascono migliaia ogni giorno, mentre per smontarne anche solo una possono servire settimane, mesi o addirittura anni di lavoro e ricerca. E spesso, mentre ne smonti una, ne sono già nate altre cento.
Per questo l’unico vero strumento è una sorta di 'vaccinazione': rendere il pubblico più consapevole, spiegare comele fake news riescono a ingannarci, quali sono i meccanismi mentali che ci portano a crederci, e soprattutto far capire come funziona il metodo scientifico.
Altrimenti, chiunque può presentarsi e fare affermazioni altisonanti, o promettere soluzioni miracolose che la scienza non si azzarderebbe mai a garantire. Ma se io ho già gli strumenti per capire come funziona la scienza, posso riconoscere al volo che quelle affermazioni non sono affidabili.
Ed è fondamentale anche parlare dei difetti del metodo scientifico, quando ci sono, invece di nasconderli come se fossero qualcosa di cui vergognarsi. Perché solo così si costruisce un rapporto di fiducia autentico tra la scienza e la società. Mostrando che sì, la scienza è a volte imperfetta, ma funziona — e per questo merita fiducia.
7. Puoi parlarci del tuo spettacolo Kosmos – la storia dell’universo (o di altri tuoi progetti teatrali)?
Come è nato, cosa vuoi trasmettere e come il pubblico reagisce alla “scienza a teatro”?
"‘Kosmos – La storia dell’universo’ nasce come una sfida. A me piace cambiare, mettermi alla prova con progetti nuovi, perché se non ho entusiasmo in quello che faccio, non posso trasmetterlo al pubblico. Lo spettacolo teatrale è stato proprio questo: una nuova sfida, un modo diverso di fare divulgazione. Non una singola data, ma un vero e proprio tour in giro per l’Italia. E devo dire che, per fortuna, è stato accolto molto bene — infatti abbiamo deciso di continuare.
Il mio obiettivo con questo spettacolo è far capire perché io trovi così affascinante il cosmo, la sua storia e l’indagine scientifica che ci permette di esplorarlo. Voglio coinvolgere quante più persone possibile nel “grande gioco della scienza”, come lo intendo io: un gioco fatto di domande, di curiosità, di pezzi di puzzle che cerchiamo di mettere insieme, pur sapendo che il quadro completo non lo avremo mai.
E voglio anche trasmettere un messaggio importante: nonostante siamo una specie minuscola, su un pianeta qualunque, in un sistema solare qualunque, in una galassia che non è speciale tra le miliardi che esistono… beh, nonostante tutto questo, quando l’umanità decide di affrontare una sfida insieme, è capace di scoperte incredibili. Abbiamo tantissimi limiti, ma anche una straordinaria capacità di cercare risposte.
E questa è la bellezza della scienza: da una singola curiosità possono nascere mille nuove domande. Non si arriva mai a un punto finale, ma ogni passo avanti ci regala qualcosa di inaspettato. È questo che cerco di raccontare sul palco."
8. La scienza è piena di domande a cui non sappiamo ancora rispondere: come vivi l’“ignoranza” in quanto scienziato e divulgatore?
È una frustrazione o una spinta a fare meglio?
"La scienza è piena di domande a cui non sappiamo ancora rispondere, ed è proprio questo il bello. Io l’ignoranza la vivo come qualcosa di legittimo, persino necessario. La cosa importante, soprattutto come divulgatore, è ammettere quando non si sa qualcosa.
Capita spesso che, durante un incontro o una conferenza, qualcuno ti faccia una domanda su un argomento che non conosci. In quel momento, la tentazione è forte: dare comunque una risposta, magari ipotizzando… ma senza dirlo chiaramente. Il rischio è far passare un’ipotesi per certezza, solo per non “svelare” che quella cosa non la sai.
Io mi sono imposto fin dall’inizio di evitare questo meccanismo. Se non so rispondere, lo dico: “Non lo so, non è il mio campo, magari possiamo informarci insieme.” È molto più onesto, e anche educativo. Perché mostra che l’ignoranza non è un difetto, ma un punto di partenza.
C’era un vecchio detto: ‘I tuttologi, quelli che sanno tutto, in realtà non sanno niente’. Ecco, io non voglio essere un tuttologo. Non è previsto che lo sia. Cerco di raccontare al meglio delle mie capacità solo ciò che conosco davvero, e come scienziato cerco di imparare — un pezzetto alla volta — consapevole che l’universo è talmente vasto che non potrò mai arrivare alla fine.
Ma alla fine, a me piace proprio questo: il gioco del sapere. Ed è un gioco che spero di continuare a fare per molto tempo."
9. Se potessi cambiare una cosa nel modo in cui la scienza viene percepita dalla società, quale sarebbe?
Cosa ti piacerebbe che la gente capisse (o smettesse di credere)?
"Se potessi cambiare una cosa nella percezione della scienza da parte della società, vorrei che venisse vista per quello che è davvero: uno strumento. Non uno strumento infallibile, non una macchina che produce certezze assolute, ma uno strumento potentissimo che l’umanità ha affilato nel corso di millenni. Uno strumento che può — e dovrebbe — aiutarci a prendere decisioni più consapevoli.
Ma attenzione: questo vale per la società, sì, ma anche per gli scienziati stessi. A volte, anche nel nostro ambiente, c’è la tentazione di pensare che la scienza sia l’unica soluzione possibile. E invece no: è uno degli strumenti che abbiamo, probabilmente uno dei migliori, ma non è l’unico. Per affrontare i grandi problemi servono anche altri approcci: etici, sociali, culturali.
La scienza non è fede, non è dogma, e soprattutto non è infallibile. Dobbiamo smettere di presentarla (e percepirla) come una bacchetta magica. Non lo è. E se ci convinciamo del contrario, rischiamo di diventare arroganti e di perdere il contatto con la realtà. La scienza non ha tutte le risposte — ma ha un metodo per cercarle. E questo è già straordinario."
10. Credi che esista un “futuro ideale” per l’umanità? E cosa significherebbe, per te?
Utopia o possibilità concreta? E la scienza che ruolo gioca?
"Non credo esista un 'futuro ideale' per l’umanità. Non perché io sia pessimista, ma perché viviamo in un sistema complesso. E attenzione: complesso non vuol dire semplicemente complicato. In fisica, un sistema complesso è qualcosa in cui non puoi prevedere il comportamento finale solo studiando le singole parti. Emergono proprietà nuove, collettive, che non derivano direttamente dagli elementi individuali.
Il simbolo più famoso di sistema complesso è lo stormo di uccelli. Io posso sapere perfettamente come vola un singolo uccello, ma la forma che assume lo stormo mentre si muove non è prevedibile semplicemente sommando quei comportamenti individuali. È qualcosa che emerge, anche a causa di piccoli eventi locali — come una singola turbolenza tra un’ala e l’altra — che si propagano a cascata e cambiano la forma dell’intero gruppo. Ecco, la società è così. L’universo stesso, spesso, funziona così.
Noi esseri umani, però, tendiamo a cercare sempre soluzioni semplici, lineari. E il rischio è di cadere nella banalizzazione invece che nella semplificazione. Vogliamo risposte facili, ma i problemi che affrontiamo non lo sono.
Quindi no, non credo ci sia un futuro perfetto. Ma credo ci siano molti futuri possibili, alcuni dei quali migliori di altri. E la scienza può aiutarci a scegliere quelli più sostenibili, più giusti, più lungimiranti. Non è l’unica strada, ma è una delle migliori che abbiamo. Non garantisce certezze né soluzioni infallibili — ma ci dà gli strumenti per orientarci nel caos, per capire, e per decidere in modo più consapevole.
In fondo, più che cercare un’utopia, forse dovremmo imparare a convivere con la complessità e ad apprezzare la bellezza del processo, del cammino. Anche se non avremo mai il puzzle completo, continueremo a trovare pezzi incredibili."
11. Qual è una domanda che vorresti ricevere più spesso, ma che quasi nessuno ti fa?
E, naturalmente… qual è la tua risposta? "Ahahah, bella domanda! Non lo so… non lo so! (ride)
Probabilmente, la domanda che mi piacerebbe ricevere più spesso è: “Parliamo davvero di teoria della scienza?”È qualcosa che quasi tutti tendono a evitare, come se fosse noiosa o troppo astratta. Nessuno ha voglia di fermarsi e dire: “Ok, adesso parliamo seriamente di come funziona la scienza, di cosa può darci e cosa no.”Eppure, se fossimo tutti più consapevoli della teoria che sta dietro alla pratica scientifica, potremmo usare molto meglio questo strumento straordinario che abbiamo. Ma ‘teoria’, purtroppo, è ancora vista come sinonimo di ‘noia’.
Poi, se invece passiamo alla mia vita personale… la domanda che sogno è:“Ti va di cercare insieme la ricetta perfetta della cacio e pepe?”E lì sì che si apre un campo di ricerca affascinantissimo!"
Con Luca Perri, la scienza non è mai solo un insieme di nozioni, ma un’avventura intellettuale da vivere con curiosità e spirito critico.
Tra telescopi e palchi, libri e spettacoli, ci ricorda che il sapere non deve essere noioso per essere rigoroso, e che il dubbio non è un limite, ma il motore della conoscenza.
In un’epoca in cui le fake news corrono veloci, il lavoro di divulgatori come lui è più prezioso che mai. E se il futuro è fatto di domande, tanto meglio: è lì che iniziano le scoperte.





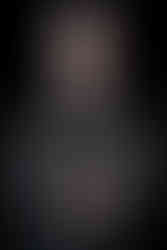






Commenti